Shanda’s River, la recensione

L’horror Shanda’s River (2018) di Marco Rosson è una chiara dimostrazione di come il cinema sia fatto innanzitutto di idee, e del fatto che si possano fare buoni prodotti anche in un sistema indipendente. Anzi, ultra-indipendente in questo caso, visto che Rosson – come riporta Nocturno.it – utilizza un budget irrisorio, girando 88 scene in soli 9 giorni complessivi di riprese. Cast artistico e tecnico sconosciuto al grande pubblico, effetti speciali artigianali, fotografia essenziale: eppure il film funziona discretamente bene, nonostante alcune pecche estetiche e narrative, ha ottenuto premi in festival di tutto il mondo ed è stato distribuito in Italia in Dvd e Blu-ray dalla label indipendente Cine-Museum – un successo niente affatto scontato per un film indipendente.
Decisamente azzeccata anche la scelta di girare il film in inglese, rendendolo più vendibile a livello internazionale e ovviando all’annoso problema del doppiaggio nel cinema indie italiano – le interpretazioni risultano dunque più credibili e professionali.
Interessante, in Shanda’s River, è innanzitutto la sceneggiatura, scritta da Nicola Pizzi, che fonde due filoni del genere horror: quello più prolifico incentrato su antiche leggende, maledizioni e streghe, e quello più raro e ricercato dove i protagonisti si trovano intrappolati in loop temporali da cui non riescono a uscire – il prototipo è il celebre fantasy Ricomincio da capo di Harold Ramis con Bill Murray, poi sfruttato in vari film di paura come Le morti di Ian Stone di Dario Piana e il recente Auguri per la tua morte di Cristopher Landon.
Shanda’s River è un horror epicorico, legato cioè al folklore e alle leggende di un determinato luogo: in Italia il re di questo genere di horror è Pupi Avati – un regista che forse Rosson aveva in mente anche per quanto vedremo in seguito – la cui lezione è stata seguita fra gli indie italiani soprattutto da Lorenzo Bianchini (Custodes Bestiae, Across the river). Rosson unisce quindi la tradizione horror del baviano La maschera del demonio, a base di streghe e maledizioni, con il filone più moderno dei loop spazio-temporali.
Rosson ambienta la vicenda nel suo paese natale, Voghera, in provincia di Pavia, dimostrando quel legame al folklore delle proprie terre tipicamente avatiano – in questo caso le macabre leggende sono totalmente inventate, ma l’effetto non cambia. La storia ha inizio con l’arrivo nella cittadina di Emma (Margherita Remotti), una professoressa universitaria giunta apposta dall’Australia per un libro che sta scrivendo sulla stregoneria: oggetto dei suoi studi è in particolare la storia di Shanda (Marcella Braga), una ragazza del posto che secoli prima fu accusata di essere una strega e barbaramente uccisa. A Voghera viene accolta da Giulia (Claudia Marasca), una ragazza che organizza dei tour sui luoghi della leggenda: alle due donne si aggiunge il giornalista investigativo Daniel Roth (Dario Runko), il quale rivela che sta indagando su misteriosi omicidi rituali compiuti in quei luoghi. Quando i tre si avventurano nel bosco circostante il fiume del titolo, vengono presto assaliti e uccisi da due cultisti con mostruose maschere demoniache. A quel punto, però, Emma si risveglia: sono le 4 del mattino dell’11 novembre 2016, ed è destinata a rivivere la stessa storia ogni giorno. Con l’aiuto di Giulia e Daniel, scopre di essere rimasta intrappolata in un loop spazio-temporale a causa di una maledizione, e cerca disperatamente un modo per uscirne e salvarsi.
Come si può intuire, la sceneggiatura mette molta carne al fuoco – forse anche troppa, visto che la storia in certi momenti risulta un po’ confusa – ma la regia riesce a tenere insieme il tutto creando una storia che appassiona lo spettatore e raggiunge più volte picchi di suspense discretamente alti. Certo, alcuni elementi non vengono chiariti del tutto – per esempio non si capisce bene il legame fra Shanda e la setta che compie gli omicidi rituali, e la natura stessa della setta (i “Redivivi”) non è ben definita: anche il finale è un po’ frettoloso, ma in fondo non ha troppa importanza, e la regia sembra concentrarsi più sull’atmosfera e la messa in scena che non sulla rigorosità dello script.
Marco Rosson, al suo secondo lungometraggio dopo New Order (uno sci-fi thriller con Franco Nero) sa fare di necessità virtù, sfruttando nel migliore dei modi gli scarsi mezzi a disposizione e trasformando alcuni semplici espedienti in risultati efficaci: per esempio, il loop temporale consente di riutilizzare alcune scene risparmiando sul girato, e gli omicidi vengono compiuti quasi tutti durante il giorno per ovviare alle difficoltà di girare scene notturne. Questo, se da un lato rischia di far perdere un po’ di fascino all’atmosfera – nella tradizione horror e thriller gli omicidi avvengono per lo più al buio – dall’altro recupera quella concezione della suspense che avevano già sperimentato Dario Argento e Pupi Avati, cioè la messa in scena di efferatezze alla luce del giorno, con un forte effetto di contrasto che spiazza lo spettatore e crea un coefficiente ansiogeno alternativo: ricordiamo l’omicidio di John Saxon nella piazza assolata dell’argentiano Tenebre, e gli orrori padani de La casa dalle finestre che ridono e Zeder.
Il rischio di un film basato sui loop temporali è la ripetitività, ma la regia di Rosson è originale e ricca di soluzioni, inventando ogni volta una morte differente per Emma – di volta in volta viene sgozzata, uccisa a colpi di mazza, squartata – e aggiungendo sempre nuovi elementi per far luce sul mistero. Gli omicidi sono ben coreografati, grazie pure al buon montaggio di Giorgio Galbiati (che è anche il produttore) e agli ottimi effetti speciali gore e splatter di Eleonorita Acquaviva, il tutto amalgamato da una regia che fa sentire un livello sempre alto di suspense e curiosità. Particolarmente inquietanti sono gli adepti della setta, mascherati e incappucciati, così come il rituale demoniaco conclusivo (questo girato al buio), ed è azzeccata la scelta delle suggestive location naturali (i boschi e il fiume, che nella realtà è il torrente Staffora); degne di nota anche le scene notturne ambientate nel passato e con protagonista Shanda, autrice di un’impressionante auto-deorbitazione dal sapore fulciano.
Pecca un po’ la fotografia, a cura di Luciano Baresi, che è abbastanza piatta, televisiva e lontana da quella profondità di campo spesso presente pure nel digitale, anche se Rosson utilizza periodicamente un particolare ed efficace effetto psichedelico dai contorni sfumati. Le musiche di Mauro Crivelli sono più che altro un tesissimo sound-design di sottofondo che accompagna la suspense senza però rimanere impresso.
Davide Comotti
| PRO | CONTRO |
|
|























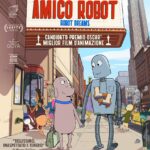















Lascia un commento