Welcome to the Blumhouse. Madres, la recensione

Siamo ormai giunti al termine del nostro tour all’interno di Welcome to the Blumhouse, la serie antologica di lungometraggi (slegati tra loro) realizzati dalla casa di produzione di Jason Blum in collaborazione con gli Amazon Studios che ne hanno poi curato la distribuzione sulla loro piattaforma Prime Video.
Chiudiamo il nostro approfondimento con Madres, ultimo degli otto episodi (distribuiti in due blocchi da quattro distanziati di un anno) che compongono quella che con certezza possiamo definire la prima edizione del progetto, ma che al momento non sappiamo se resterà l’unica o avrà un seguito. È chiaro che prima di pronunciarsi in questo senso, Blum e soci attendano il riscontro in fatto di visualizzazioni, vero e proprio parametro vitale prima ancora di un giudizio critico. Anche perché, a dirla tutta in termini critici, il bilancio complessivo non è esattamente lusinghiero.
La costante di questi film sembra essere quella di avere, chi più chi meno, degli input potenziali (spesso di natura sociale) che poi non vengono sfruttati in maniera adeguata se non addirittura gettati alle ortiche. In diverse occasioni, l’impressione è che bastasse poco per elevarsi sopra una media generale livellata verso il basso. A conti fatti, mi sono ritrovato con una sensazione/convinzione simile a quella che mi aveva lasciato Into the Dark – l’altra serie antologica targata Blumhouse che in Italia era arrivata grazie alla RAI, ovvero che le storie e le idee raccontate avrebbero potuto funzionare meglio sul mediometraggio, una durata di 50/60 minuti magari più funzionale agli spunti interessanti che invece sul minutaggio più lungo venivano puntualmente vanificati, alla stregua di una vera serie tv composta da episodi autoconclusivi accomunati da tematiche orrorifiche e/o fantastiche.
Insomma, un po’ quello che aveva fatto Mick Garris per Showtime con la riuscitissima Masters of Horror, episodi da 60 umilissimi minuti al servizio di storie e, soprattutto, manici che Jason Blum non ha visto nemmeno di striscio, con l’autorete del fugacissimo cameo proprio di Garris in The Manor (ve ne eravate accorti?), con la mente che inevitabilmente riporta al 2005/2007 ed alla suddetta antologia dei maestri dell’orrore.
Madres non sfugge a questa regola infausta. Il suo punto di forza è la sua natura da horror sociale, che spinge forte sulla critica superando quel confine che la rende denuncia vera e propria. Non a caso, il film si ispira (dichiarandolo in apertura) a fatti realmente accaduti che verranno poi snocciolati sui titoli di coda. Il tema è quello della sterilizzazione coercitiva (e inconsapevole), un controllo delle nascite coatto e selettivo; nel corso del 20° secolo circa 64 mila individui sono stati sterilizzati negli Stati Uniti a causa del National Eugenics Movement, che fondava le proprie ragioni (illegali ed immorali) nel razzismo limitando i diritti riproduttivi di coloro che venivano considerati geneticamente inadatti. Nello specifico, la sceneggiatura si basa su un episodio accaduto nel 1975, quando un gruppo di donne immigrate messicane portò avanti una class action contro un ospedale di Los Angeles in cui erano state sterilizzate senza consenso, perdendo la causa che non porterà mai giustizia alle vittime.
In sostanza, l’argomento è forte per tematica e delicato per il modo in cui va affrontato. Se poi, di riflesso, ci aggiungiamo temi come razzismo, pregiudizio, lotta di classe, integrazione, condizioni di lavoro dei migranti, abuso di pesticidi in agricoltura, allora ecco che la patata diventa bollente. Per arrivare ad una morale conclusiva sul combattere per ciò che è giusto anche se questo fa paura. Peccato, però, che la patata si sgretoli presto manco fosse purè andato a male, tutto o quasi vanificato da quella che di base dovrebbe essere la natura portante del progetto, quella più marcatamente orrorifica.
A quel punto, era paradossalmente meglio slegare il film dalla serie e puntare sul dramma puro con più possibilità per il messaggio di riuscire ad andare realmente in porto. L’horror sembra intruso, inserito a forza, senza cognizione di causa. A partire dalla scelta del sottogenere che denota palese confusione, una crisi d’identità che infila momenti soprannaturali per poi virare su minacce decisamente più terrene, visioni oniriche a cui non viene fornita grossa profondità quando invece il pericolo si rivela di altra matrice.
A conti fatti, gli eventi realmente accaduti sono molto più inquietanti degli elementi vagamente sinistri appiccicati allo script per travestire da horror un film che nell’anima non lo è. E dire che una didascalia in apertura lo aveva pure sottolineato: ‘Non credere che l’origine del male sia soprannaturale, gli uomini sono capaci da soli di ogni malvagità’. Salvo poi mandare la coerenza in malora con un maldestro tentativo di depistaggio che finisce per confondere le idee sia degli autori che dei fruitori.
La ricostruzione ambientale non prevede sforzi eccessivi, siamo negli anni 70 ma la realtà rurale della comunità agricola permette di contenere gli slanci scenografici e dei costumi. La location che funziona meglio è la vecchia casa in cui si trasferisce la coppia di protagonisti. Grossa e fatiscente, con croci fissate sopra ogni porta a testimonianza di una maldiciòn da contrastare. Un luogo in cui la combinazione di passi e legno scricchiolante genera rumori che alimentano la suggestione.
La dimora di Beto e Diana – interpretati con aderenza da Tenoch Huerta e Ariana Guerra, giovane coppia che cerca di superare la differenza d’estrazione sociale (e l’ostracismo di contorno che ne deriva) attraverso unione e sentimenti. Una relazione che gioca sul capovolgimento dello stereotipo che siamo abituati a vedere, con l’americana (per quanto di origine latina) che cerca di integrarsi a fatica tra i messicani mentre, nella sfera professionale, non riesce a raccogliere i frutti di studi e preparazione culturale a differenza del marito che, nonostante le umili origini, scala le posizioni all’interno dell’azienda agricola grazie ad impegno e perseveranza.
Da segnalare gli svariati dialoghi in lingua spagnola, che nella versione italiana vengono giustamente lasciati con audio originale con l’unica controindicazione del protagonista che in questo modo finisce per avere due voci abbastanza diverse tra loro per un effetto straniante chiaramente tutto nostrano.
Madres è il primo lungometraggio in carriera per il regista Ryan Zaragoza che qualche suggestione la indovina pure, perdendosi però in una direzione indecisa e poco incisiva che di certo non viene aiutata da uno script confuso ed esitante come quello di Marcella Ochoa e Mario Mischione. Ma non disperate, una buona notizia c’è: Welcome to the Blumhouse è giunta al termine. E se le premesse sono queste, non ci offendiamo se non dovesse proseguire ulteriormente.
Francesco Chello
| PRO | CONTRO |
|
|
























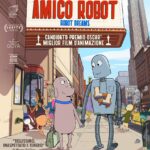
















Lascia un commento