Into the Dark: Tutto distrutto, la recensione

Ottavo appuntamento con Into the Dark, la serie antologica targata Blumhouse destinata al circuito televisivo, recentemente distribuita in Italia da RaiPlay. Una serie di lungometraggi slegati tra loro, dodici (a stagione) come i mesi dell’anno, il cui unico punto in comune è quello di svolgersi durante una festività.
La ricorrenza di riferimento di All That We Destroy (Tutto Distrutto) è la Festa della Mamma anche se, in realtà, parliamo in linea assolutamente teorica visto che l’evento non viene nemmeno nominato nel corso del film. Il riferimento vero è la madre.
La storia ruota intorno alla figura materna, al rapporto madre/figlio, a ciò che un genitore arriva a fare per un figlio, superando talvolta limiti morali, di coscienza e dignità. Persino limiti di etica professionale come nel caso della protagonista, brillante medico genetista, che nel disperato tentativo di reprimere l’istinto omicida del figlio, crea dei cloni femminili su cui il ragazzo possa sperimentarsi e lavorare su sé stesso.
Il fulcro contenutistico si rivela quindi un aspetto interessante del film, una riflessione sul lato oscuro e pericoloso dell’essere genitore, quando il troppo amore può trasformarsi in follia, il sentimento offusca la lucidità, credere di proteggere il proprio figlio da una situazione finendo solo per peggiorarla, annullare la propria persona per il benessere altrui, perdere il contatto con una realtà che non si accetta insistendo in qualcosa che può fare male a sé stessi e, soprattutto, agli altri. Spesso si dice che un genitore ucciderebbe per il proprio figlio, un concetto metaforico che qui diventa letterale.
Il messaggio non è l’unico aspetto positivo di All That We Destroy che indovina anche un meccanismo narrativo fatto di ricostruzione, flashback e piano temporale sfalsato. Si entra praticamente subito nel vivo, col primo omicidio già nel prologo. I personaggi svelano strada facendo i loro trascorsi, delineando profili di determinate situazioni che poi si scoprono essere differenti. La trama di fondo magari non si distingue per originalità ma trova la sua efficacia nel modo in cui viene raccontata, lo stesso finale probabilmente intuibile si mostra coerente col filo conduttore, quasi doveroso a quel punto. Uno script, quindi, attento e funzionale quello di Sean Keller e Jim Agnew, due che possono ̶v̶e̶r̶g̶o̶g̶n̶a̶r̶s̶i̶ vantarsi di aver scritto Giallo di Dario Argento, esperienza curricolare che crea una diffidenza forse legittima. Sceneggiatura che viene ottimizzata dalla regia calibrata e visivamente interessante di Chelsea Stardust (nome d’arte di Chelsea Peters), una di casa Blumhouse vista la gavetta come assistente di Jason Blum, che qualche mese prima aveva esordito su un lungometraggio con Satanic Panic.
Il quadro scenografico si sposa con un budget certamente contenuto, viene valorizzato da una fotografia dai colori freddi, grigiastri, in linea col tono generale. Il grosso delle sequenze si svolge all’interno della villa degli Harris, circondata dal nulla del deserto. Enorme, minimalista ma curata, un ambiente freddo, asettico. Siamo in un futuro non troppo lontano. Le auto sono praticamente le stesse, gli smartphone ed i tablet sono leggermente diversi (e sono pure sfiziosamente cool nel loro design vitreo), Alexa e Siri hanno fatto passi da gigante. Le videochiamate avvengono a livello neurale, creando una realtà virtuale in cui i due interlocutori possono condividere lo stesso luogo fittizio. E, cosa più importante, una genetista può creare cloni umani nel laboratorio di casa.
I due protagonisti si mostrano in linea con lo scopo del racconto. Israel Broussard è Spencer, ragazzo disturbato e problematico; il merito dell’attore è quello di renderlo repulsivo a pelle, creare una sorta di immediata e disagevole incompatibilità con lo spettatore. Samantha Mathis (già presente in serie come Under the Dome e The Strain) è una madre che cerca di nascondere una disperazione che invece il suo viso lascia trasparire, una donna che crede di avere il controllo quando invece si trova ad un passo dallo sbando. Al loro fianco, Aurora Perinnau (Obbligo o Verità) nel ruolo volutamente disorientato dei cloni, mentre Dora Madison (Exists – film sul Bigfoot che già che ci sono vi consiglio) è l’ingenua e invadente Marissa. Cameo di Frank Whaley, nei panni di un personaggio la cui parentela sarà svelata in corso d’opera – e su cui sarebbe stato lecito saperne di più.
All That We Destroy (tradotto letteralmente ‘tutto quello che distruggiamo’, titolo più incisivo della variante italiana che diventa Tutto Distrutto) si può annoverare tra gli episodi riusciti di questa prima stagione di Into the Dark. Riesce a mantenere costante l’attenzione conciliando una gestione decorosa di temi delicati, momenti di fastidio e violenza, un impianto narrativo sufficientemente stimolante ed un comparto visivo vagamente intrigante.
Francesco Chello
| PRO | CONTRO |
|
|
























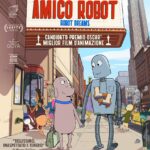














Lascia un commento