Il prigioniero coreano, la recensione

«Fai attenzione: oggi la corrente va verso Sud», lo avvisa una sentinella, ma a fare sempre molta attenzione, il pescatore Nam Chul-woo (Ryoo Seung – bum) ci è abituato. Non puoi permetterti distrazioni quando abiti in un villaggio della Corea del Nord e ti muovi ogni giorno sulla linea di confine, all’altezza del 38° parallelo. Confine d’acqua, nel caso di Nam, ed è proprio l’acqua a tradirlo: una delle reti si aggroviglia attorno all’elica della sua piccola barca, il motore si blocca e la corrente che «va verso Sud» trascina lentamente e inesorabilmente il pescatore in zona nemica: la Corea del Sud. Nam si ritroverà letteralmente imprigionato tra le due ideologie.
Il prigioniero coreano, presentato al 73° Mostra del Cinema Di Venezia nel 2016 e in uscita in Italia il 12 aprile, grazie alla distribuzione della Tucker Film, è il nuovo film del sudcoreano Kim Ki-duk. L’osannato regista di Primavera, estate, autunno, inverno…e ancora primavera (2003), Ferro 3 – La casa vuota (2003) con cui vinse il Leone d’argento alla Mostra del cinema di Venezia, e Pietà, Leone d’oro nel 2012, torna alle origini, presentando un thriller dell’anima.
Riuscirà Nam, dopo pressanti interrogatori, a convincere le forze di sicurezza sudcoreane di non essere una spia? Ma soprattutto: riuscirà Nam, dopo il proprio faticoso rilascio, a convincere il potere nordcoreano della propria integrità? È rimasto un bravo cittadino devoto al regime o l’infezione del capitalismo lo ha contaminato per sempre?
Kim Ki-duk presenta una narrazione politica, utilizzando il tema del doppio, così com’è doppia la Corea e raccontando una grande storia collettiva attraverso la vicenda e di un singolo individuo innocente. Kim Ki-duk parla di una nazione divisa ed in perenne stato di guerra, utilizzando, a modo suo, la grammatica del thriller. Un racconto a specchio per descrivere due facce della stessa medaglia dove le reti da pesca assumono un significato quasi allegorico, diventando rappresentazione di due reti ideologiche contrapposte che, in qualche modo, si bilanciano per perpetuare il controllo del potere. La Corea del Nord e quella del Sud divengono simbolo delle differenze fra l’occidente ed il comunismo. L’odissea di Nam Chul-woo ha il compito di ritrarre, con drammatica lucidità, le divergenze tra i due sistemi: cultura, ideologie, quotidiano.
Dimenticate il cinema filosofico e metafisico di Ki-duk. Il prigioniero coreano è fortemente ancorato alla realtà contemporanea, alla politica, alla condizione umana, fisica e materiale. Niente slanci autoriali o particolari raffinatezze cinematografiche. Anzi, per dirla tutta, a tratti il film appare scolastico e colonizzato da figure stereotipate. Non è la forma che interessa al regista, questo è evidente, piuttosto è la sostanza che è in grado di trasmette allo spettatore senso di oppressione e claustrofobia. Kim Ki-duk non ha nessuna intenzione di essere frainteso e sceglie un linguaggio crudo, diretto e fisico, escludendo giudizi definitivi e raccontando la dignità di un uomo che sa di essere in un vicolo cieco e non vuole piegarsi. Un uomo che non si arrende e che vuole, semplicemente, tornare a casa dalla sua famiglia. Un povero Cristo costretto a scontrarsi prima con le insostenibili diffidenze del regime che opprime la sua terra e poi con la disillusione di un sistema di vita e di pensiero che, tutto sommato, non avrebbe mai voluto conoscere. Un uomo che incarna nello stesso corpo le due coree.
Il prigioniero coreano è un film che non piacerà né al di qua né al di là del 38° parallelo. Il messaggio è decisamente scomodo per entrambe le parti in causa. La popolazione della Corea del Nord molto probabilmente non lo vedrà mai e di sicuro anche al Sud non avrà vita facile. Da un lato e dall’altro della frontiera, che separa le due Coree, brutture e ingiustizie speculari e ugualmente deleterie, schiacciano l’individuo. L’intera opera diviene metafora del concetto di yin e yang.
Lo yin e yang sono opposti: qualunque cosa ha un suo opposto, non assoluto, ma in termini comparativi. Nessuna cosa può essere completamente yin o completamente yang; essa contiene il seme per il proprio opposto. Lo yin e lo yang, così come le due coree, hanno radice uno nell’altro: sono interdipendenti, hanno origine reciproca, l’uno non può esistere senza l’altro.
Forte di questo concetto, Kim Ki – duk non fa sconti a nessuno, non salva nessuno, non indora la pillola e utilizza l’unico modo possibile per descrivere onestamente una realtà che conosce bene: suo padre ha combattuto la Guerra di Corea. Per i coreani la divisione è una ferita che sanguina da 70 anni. Con quest’opera vuole mostrare un paradosso e farci vedere come sono simili Nord e Sud.
Si avverte in Kim Ki-duk il dolore per una separazione che consente di mantenere un regime di terrore da una parte e dall’altra concede la giustificazione per costruire una società basata sul sospetto, per cui ogni persona può essere considerata infida e spia. Il Sud che racconta non sembra felice e non sembra “libero”. Al Sud incontra uomini dotati di un’arroganza di segno uguale e contrario a quella dei potenti del Nord. Certo, si vive meglio che al Nord, non c’è dubbio, ma poi, non è tutto oro quel che luccica. Là c’è la dittatura, qui la violenza ideologica. Là c’è la propaganda del duro regime, qui l’inferno capitalistico, provocante come il canto delle Sirene per Ulisse, dinanzi al quale bisogna chiudere gli occhi, per non correre il rischio di esserne tentati. Le scene più toccanti sono proprio quelle “ad occhi chiusi”. Come l’eroe dell’Odissea di Omero ed i suoi compagni, che tentarono di tapparsi le orecchie con la cera per non sentire il canto delle ammaliatrici Sirene, il nostro si costringe in un pellegrinaggio “ad occhi chiusi” per non subire il fascino del consumismo, tra le vie tentatrici di Seul. Non mancheranno segni degradati della società capitalistica che indurranno Num a chiedersi in cosa consista la democrazia. La risposta sarà potentissima ed emblematica: “Dove c’è una forte luce c’è sempre anche una grande ombra”. Un’epifania.
Il prigioniero coreano è una parabola, un po’ come quelle di Gesù raccontate nei Vangeli, che risulta più efficace e chiara di tanti documentari, approfondimenti, reportage fotografici della carta stampata e della televisione. È un dono che l’arte cinematografica fa alla storia contemporanea. La visione critica e dolorosa del mondo fa parte della vocazione di Kim Ki-duk: grande autore e voce profetica che non dovrebbe mai passare inosservata e inascoltata. Maestro di parabole necessarie.
Potete leggere un’altra recensione de Il prigioniero coreano, in occasione della sua presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2016, cliccando qui.
Ilaria Berlingeri
| PRO | CONTRO |
|
|





























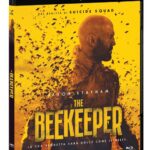










Lascia un commento