Sweet Country, Il ritorno dell’Australian New Wave al Festival di Karlovy Vary

Il western è il genere chiave dell’identità nazionale americana, sia nella sua versione classica, che esaltava il mito della colonizzazione della frontiera, sia in quella “revisionista” esplosa a fine sessanta, che lo ripudiava, adottando per la prima volta il punto di vista dei nativi e individuando una sostanziale continuità tra l’etnocidio degli indiani compiuto nel XIX secolo e l’imperialismo globale del XX. Allo stesso modo, il cinema australiano scopriva l’identità aborigena nel corso degli anni settanta, con una serie di pellicole che, in vario modo, hanno tutte evidenziato una lacerante contraddizione tra lo “stato di natura” della cultura locale e il “Leviatano” della modernità coloniale. Basti citare i classici di Peter Weir Picnic ad Hanging Rock (1975) e L’ultima onda (1977) o le due produzioni britanniche L’inizio del cammino (1971), di Nicolas Roeg, e L’australiano (1978), di Jerzy Skolimowski.
Premio speciale della Giuria all’ultima Mostra di Venezia, ripreso a Karlovy Vary nella sezione “Horizonty”, Sweet Country (2017) si colloca autorevolmente in questo solco, confrontandosi anche con un più recente filone del cinema di Hollywood, quello sulla condizione afroamericana nell’età dello schiavismo, aperto da Django Unchained (2012) e proseguito con 12 anni schiavo (2013) e The Birth of a Nation (2016). Il regista Warwick Thornton ha sangue aborigeno e, soprattutto, una solida visione autoriale da sempre focalizzata sulla cultura nativa australiana, dal film Caméra d’Or a Cannes Samson and Delilah (2009), ai documentari della serie Art + Soul (2010), al collettaneo Words With Gods (2014).
Siamo nel 1929, in una zona rurale semidesertica della meno urbanizzata tra le regioni australiane, il Territorio del Nord. Sam Kelly (Hamilton Morris) è un contadino aborigeno di mezza età, assimilato allo stile di vita coloniale dal proprietario terriero Fred Smith (Sam Neill), un fervente cristiano. L’arrivo in un vicino appezzamento del reduce di guerra Harry March (Ewen Leslie), alcolista, violento e incline a trattare gli aborigeni come schiavi, rompe un fragile equilibrio. Harry violenta Nell (Natassia Gorey Furber), la moglie di Sam, poi attacca la coppia barricata in casa a colpi di fucile, finendo ucciso per inequivocabile legittima difesa. Sam sa però che non potrebbe dimostrare le proprie ragioni di fronte ai bianchi e fugge con la moglie nelle sterminate distese dell’outback, inseguito dall’arcigno sergente Fletcher (Bryan Brown).
Sweet Country si colloca dunque a pieno titolo nell’ambito del genere western, per ambientazione e struttura narrativa, e propone un finale di stampo procedural, con il processo celebrato sulla main street di un villaggio in tutto simile a quelli del vecchio West americano. Un carattere squisitamente nazionale emerge, d’altra parte, anzitutto nell’estetica, con ripetuti e brevissimi flashforward ad anticipare il destino di ogni personaggio alla sua prima apparizione in scena, nell’inconfondibile stile onirico dell’Australian New Wave di Weir, Roeg e George Miller.
La condizione aborigena appare qui come una terribile sintesi tra quella dei nativi indio e quella degli afroamericani, sommando l’etnocidio alla schiavitù di fatto. L’aspetto più impressionante della solitudine del protagonista è la sua totale alterità, non soltanto rispetto ai colonizzatori bianchi, ma anche rispetto agli altri aborigeni, ancora organizzati in strutture tribali pre-moderne. Lo stesso rapporto con la moglie, vittima di stupro, è reso difficile da un senso dell’orgoglio e dell’onore di origine culturale del tutto ibrida. Il ruolo del caritatevole e bigotto Smith appare, in tal senso, non meno sinistro di quello degli altri coloni.
Enrico Platania



























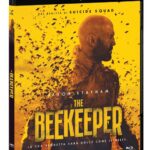











Lascia un commento