Orrore e società: un viaggio attraverso le generazioni

New York, anni ’60. Una giovane coppia si trasferisce in uno dei palazzi più antichi e sfarzosi della città. Nonostante un amico li ammonisca riguardo sinistre leggende legate al palazzo, Rosemary e Guy non si fanno intimorire e iniziano la loro nuova vita entusiasti e pieni di speranze. Dopo aver appreso del suicidio di una ragazza e aver fatto la conoscenza dei singolari anziani che la ospitavano, i nuovi inquilini inizieranno a subire le morbose attenzioni della coppia di vicini che si insidieranno sempre più nell’intimità dei due giovani. Rosemary, che nel frattempo è rimasta incinta, diventa sempre più sospettosa, paranoica e intimorita dal comportamento di Minnie e di suo marito Roman che sembrano interessanti tanto a Guy quanto al nascituro.
Il genere horror ha attraversato svariate epoche che lo hanno fortemente caratterizzato: dai romanzi gotici ottocenteschi al più recente terrore psicologico di stampo hitchcockiano, passando per l’interesse degli autori di genere per le tematiche fantascientifiche. Ma possiamo individuare una specifica annata per sancire la nascita dell’horror cosiddetto “moderno”, il 1968. In quell’anno, infatti, per la Paramount uscì Rosemary’s Baby, esordio hollywoodiano di un giovane e talentuoso regista europeo, Roman Polanski, mentre il cinema indipendente americano vide il memorabile esordio di un autore che sarebbe diventato in futuro uno dei maestri del genere, George A. Romero con il suo La notte dei morti viventi.
Se Psyco puntava alle urla dello spettatore attraverso le pure immagini, Rosemary’s Baby e La notte dei morti viventi vertevano su una definizione più amara e politica, il terrore come mezzo per fotografare una società sempre più decadente. Il film di Romero fu una chiara condanna agli orrori della guerra, al razzismo e ai profondi paradossi della società americana, mentre il capolavoro dell’occulto di Polanski denunciava senza mezzi termini la deriva arrivista in cui stava tristemente scadendo l’occidente e buona parte della sua gioventù.
Tornando ai giorni nostri, la decade duemiladieci ha visto nascere nuove stelle per quanto riguarda il panorama horror: Robert Eggers ha letteralmente “stregato” il pubblico internazionale con The VVitch (2015), un film tanto sconvolgente quanto profondamente “antropologico”. Al netto del perfetto mix di generi e di atmosfere orchestrate dal regista all’interno del suo lavoro, The VVitch funge da vera e propria riflessione sul male e sul barbicare di esso nei meandri più sinistri dell’animo umano. La conferma del talento di Eggers è il chiacchieratissimo The Lighthouse (2019), che ha come protagonisti i magnifici Robert Pattinson e William Dafoe. Il film è una fucina di lampi espressionisti degni del miglior Fritz Lang, controprova del fatto di quanto i nuovi autori di genere dimostrino una certa avversione per le etichette e non abbiano alcuna velleità di piacere forzatamente al grande pubblico.
Se è vero che Eggers ha contribuito a riaccendere i riflettori sul cinema di genere con un occhio ai maestri del passato (in The VVitch sono palesi i riferimenti ad autori come Dreyer e Kubrick mentre in The Lighthouse le citazioni agli autori espressionisti tedeschi si sprecano, Murnau e Lang su tutti), un altro giovane americano ha piantato la sua personale bandierina in questo fantastico e redivivo universo dell’orrore cinematografico: Ari Aster.
A caratterizzare lo stile di Aster ci sono il deciso contrasto tra una fotografia pulita e quanto mai splendente, limpida e volta a catapultare lo spettatore in un’atmosfera onirica e di pace apparente e l’incubo più sconvolgente, l’orrore che si consuma alla luce del sole, il buio che sembra non esistere in questo mondo surreale e profondamente agghiacciante in cui ci viene mostrato realmente tutto ciò che accade, senza filtri. Dopo il sorprendente Hereditary, Ari Aster si conferma come uno degli autori di genere più brillanti della scena e con Midsommar ha totalmente smosso le anime cinefile e tra i complimenti raccolti dal regista statunitense spiccano quelli del regista di Scappa – Get Out Jordan Peele e soprattutto quelli del maestro Martin Scorsese che ha definito l’opera seconda di Aster come qualcosa che “scava in emozioni reali e profondamente scomode“, tanto da prendersi la responsabilità di glorificare con le sue parole l’introduzione alla versione “Director’s cut” del film.
Ari Aster per il futuro ha già annunciato di avere in progetto una “commedia da incubo” di quattro ore ma ha voluto sottolineare la sua gratitudine e il suo amore verso il cinema horror dichiarando che “Potrebbero volerci alcuni film prima di tornare alle origini, ma adoro l’horror e sono sicuro che tornerò ad occuparmi di quel genere”.
A proposito di Jordan Peele, l’ex comico responsabile della rinascita ‘black’ del cinema horror, la sua svolta registica del 2017 con il sorprendente Scappa – Get Out lo ha reso iscrivibile tra gli autori che con la loro poetica hanno scosso l’opinione pubblica e i famigerati benpensanti di tutto il mondo. Prodotto da Blumhouse, Peele ha scelto di affrontare il tema del razzismo con un film sconvolgente e diverso da tutti gli altri prodotti che negli ultimi anni hanno provato a scavare nel merito della questione. Scappa – Get Out ridicolizza e si prende gioco dei cliché della borghesia bianca americana, in poco più di un’ora e mezza distrugge la demagogia tipica dell’America più conservatrice e razzista degli anni dieci del duemila e permette a Blumhouse di ottenere la sua prima storica candidatura agli Oscar del 2018.
Con Us – Noi, Jordan Peele continua la ricerca antropologica che aveva interrotto con Scappa – Get Out e ci regala un’altra inquietante fotografia della società moderna: una tipica famiglia americana torna nella casa vacanze dei nonni materni e quello che li aspetta è una sorpresa tanto terrificante quanto significativa. Lo spettatore è risucchiato in una guerra senza quartiere ai propri mostri ed è costretto ad una continua interrogazione della propria coscienza, lungo la durata di tutto il film. Il regista era chiamato a confermarsi e non ha tradito le aspettative, la pellicola è zeppa di citazioni e riferimenti alla cultura pop, la fotografia è curata al dettaglio e alcune scene risultano essere davvero memorabili. Il ritmo del film è frenetico ed è caratterizzato da picchi di tensione altissima e momenti di ilarità e leggerezza, approccio che gli estimatori del primo lavoro dell’autore americano hanno già imparato a conoscere. Peele dimostra di muoversi perfettamente nell’universo dei film di genere e conferma, una volta di più, di avere uno stile davvero personale e ben distinto. Un’altra nota di merito va ad un cast davvero ben assortito e guidato da una strabiliante Lupita Nyong’o, le sue smorfie e la sua capacità di entrare nel personaggio valgono da sole il prezzo del biglietto e apprezzamenti da praticamente tutto l’universo cinema per il secondo film di Peele.
Sempre per quel che riguarda il genere horror attuale, è giusto citare anche un autore con un respiro certamente più di nicchia, Oz Perkins. Figlio del più celebre Anthony Perkins (indimenticato volto di Norman Bates in Psyco di Alfred Hitchcock), Perkins ha diretto film convincenti solo in parte ma sembrerebbe avere la stoffa per rimanere comunque nell’immaginario collettivo dei film di genere. Dopo February – L’innocenza del male, film intimista e profondamente malinconico che attraverso immagini cruente ed evocazioni demoniache fotografa il significato di perdita secondo il regista newyorkese, firma con Netflix per una produzione a basso costo dal titolo Sono la bella creatura che vive in questa casa, una ghost stories dal sapore vintage ed esistenzialista che finisce però per essere svilita dalla discutibile originalità della storia già vista e rivista (il film, non è chiaro se più o meno consapevolmente, nelle battute iniziali ricorda incredibilmente A Ghost Story di Lowery).
L’ultima fatica di Perkins invece è stata Gretel e Hänsel, titolo modificato con cognizione di causa per sottolineare il ruolo centrale della figura femminile di Gretel all’interno della pellicola. Coerentemente con i suoi lavori precedenti, Perkins pone la figura femminile al centro del progetto ma questa volta non si limita solo a dare il suo personale contributo alle quote rosa nel mondo del cinema, sviscera profondamente il concetto di discriminazione di genere (ci regala anche un dialogo sul femminismo intelligente e per nulla banale), riuscendo nell’impresa di ridisegnare alcuni personaggi della fiaba per renderli funzionali ai temi trattati con una lucidità rara e un talento non comune. Se è vero che la fotografia si sposa meravigliosamente con le tipiche atmosfere da fiaba tedesca, lo script lascia indietro qualcosa, difetto che fa il palio, oltre che con una riuscitissima caratterizzazione dei personaggi, anche con un importante lavoro sull’utilizzo dei colori e sulla composizione delle immagini, spesso memorabili e peculiari.
Al netto del momento difficile che vede le produzioni cinematografiche boccheggiare causa coronavirus, attendiamo con passione nuove uscite e nuovi autori che possano, una volta di più, rendere omaggio al genere che nonostante le difficoltà degli ultimi vent’anni rimane tra i più amati e i più gloriosi dell’intera storia dell’audiovisivo.
Andrea Di Pede



























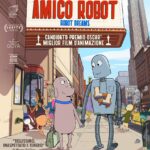














Lascia un commento